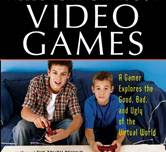Quando la storia entra in "gioco"
(di Luigi Marrone)
(di Luigi Marrone)
 E’ profondamente esaltante tirare fuori l’arma in Mass Effect.
E’ profondamente esaltante tirare fuori l’arma in Mass Effect.Udire poi il suono pressurizzato dei servo-motori delle tute dei compagni, leggermente defilati dietro noi, lo é altrettanto.
Si tratta di un semplice gesto, di una semplicissima interazione presente in centinaia di altri giochi, vale a dire premere X e osservare su schermo il proprio alter-ego armarsi, pronto all'azione.
In Mass Effect però é diverso: si tratta di un'azione carica di significato.
La tangibile sensazione di trovarsi in un pianeta estraniato, soli e in avanscoperta con l’arma puntata verso un angolo di una parete, oltre una roccia - ordinando ai propri compagni di mettersi a riparo dietro quella porta – il “bip” di ricezione del comando nei loro caschi - mentre il fervore di un ambient sound digitale punta dritto alle emozioni – in Mass Effect è semplicemente qualcosa di impagabile.
Dai riflessi tralucenti sulle tute spaziali alle sinuose/rarefatte ambientazioni sci-fi Mass Effect è un gigantesco omaggio alla Space Opera, ai nerd della fantascienza e agli invasati di science fiction quale il sottoscritto, per la precisione.
E’ stato appurato che qualche altro mese di sviluppo avrebbe fatto senz’altro benissimo a Mass Effect: non è difatti mistero che l’IA dei compagni di squadra sia molto più che molliccia, talvolta imbarazzante visto l’insigne portato serioso dell’opera. E’ davvero fuori luogo sentir dire “Ci vorrebbe un trasporto aereo!” quando si è ordinato loro solamente di seguirci sulle scale, oppure assistere ad un incomprensibile, testardo sparare nel bel mezzo di un muro solo perché il nemico è in linea di tiro oltre il muro stesso.
Senza contare l’aggiornamento delle texture che avviene anche svariati secondi dopo l’avvio di una cut-scene, nonché i vistosi cali di frame rate sintomo di una CPU mal governata e in piena crisi di calcolo.
Ma resta il fatto che é profondamente esaltante tirare fuori l’arma in Mass Effect.
La tangibile sensazione di trovarsi in un pianeta estraniato, soli e in avanscoperta con l’arma puntata verso un angolo di una parete, oltre una roccia - ordinando ai propri compagni di mettersi a riparo dietro quella porta – il “bip” di ricezione del comando nei loro caschi - mentre il fervore di un ambient sound digitale punta dritto alle emozioni – in Mass Effect è semplicemente qualcosa di impagabile.
Dai riflessi tralucenti sulle tute spaziali alle sinuose/rarefatte ambientazioni sci-fi Mass Effect è un gigantesco omaggio alla Space Opera, ai nerd della fantascienza e agli invasati di science fiction quale il sottoscritto, per la precisione.
E’ stato appurato che qualche altro mese di sviluppo avrebbe fatto senz’altro benissimo a Mass Effect: non è difatti mistero che l’IA dei compagni di squadra sia molto più che molliccia, talvolta imbarazzante visto l’insigne portato serioso dell’opera. E’ davvero fuori luogo sentir dire “Ci vorrebbe un trasporto aereo!” quando si è ordinato loro solamente di seguirci sulle scale, oppure assistere ad un incomprensibile, testardo sparare nel bel mezzo di un muro solo perché il nemico è in linea di tiro oltre il muro stesso.
Senza contare l’aggiornamento delle texture che avviene anche svariati secondi dopo l’avvio di una cut-scene, nonché i vistosi cali di frame rate sintomo di una CPU mal governata e in piena crisi di calcolo.
Ma resta il fatto che é profondamente esaltante tirare fuori l’arma in Mass Effect.
Perché dopo che l’universo ha preso forma attraverso un design degli ambienti stupefacente, dopo che le espressioni facciali e la musica e i sound effects ti hanno spintonato a velocità iper-luce dentro un universo narrativo solido, vivo e palpitante, a quel punto la storia che muove Mass Effect non può più essere considerata una mera funzione del gameplay, ma entra di diritto nel gameplay stesso, caricando l’interazione di un profondo significato.
E’ per questo che non è difficile immedesimarsi o impegnarsi più di tanto per sentirsi complici con l’esperienza Bioware, in quanto Mass Effect regala l’emozione d’interagire in un contesto narrativo in grado di avere peso, di significare.
Cosi come Bioware è riuscita ad abituare i gamers negli anni, la coerenza ludo-narrativa del gioco è cosa profondamente spiazzante.
 Nella corsa al fotorealismo grafico e alle comparazioni di potenza video degli attuali sistemi di intrattenimento, l’in più di Mass Effect è sorprendentemente la cosmesi cinematografica della quale ogni singolo dettaglio è caratterizzato.
Nella corsa al fotorealismo grafico e alle comparazioni di potenza video degli attuali sistemi di intrattenimento, l’in più di Mass Effect è sorprendentemente la cosmesi cinematografica della quale ogni singolo dettaglio è caratterizzato.
Perché é normale, anzi logico e dovuto che un testo videoludico profondamente narrativo non possa far altro che evolversi in un comparto audiovisivo fortemente esplicativo.
Solo che Mass Effect lo fa, e con risultati migliori di quanto visto sin’ora, riuscendo ad offrire l’Universo con tutto il suo carico di inquietudine e suggestioni, di solitudine e abbandono, di ignoto e tecnologia che solo una grande Space Opera cinematografica o un grande romanzo sci-fi potrebbero permettersi.
E’ per questo che non è difficile immedesimarsi o impegnarsi più di tanto per sentirsi complici con l’esperienza Bioware, in quanto Mass Effect regala l’emozione d’interagire in un contesto narrativo in grado di avere peso, di significare.
Cosi come Bioware è riuscita ad abituare i gamers negli anni, la coerenza ludo-narrativa del gioco è cosa profondamente spiazzante.
 Nella corsa al fotorealismo grafico e alle comparazioni di potenza video degli attuali sistemi di intrattenimento, l’in più di Mass Effect è sorprendentemente la cosmesi cinematografica della quale ogni singolo dettaglio è caratterizzato.
Nella corsa al fotorealismo grafico e alle comparazioni di potenza video degli attuali sistemi di intrattenimento, l’in più di Mass Effect è sorprendentemente la cosmesi cinematografica della quale ogni singolo dettaglio è caratterizzato.Perché é normale, anzi logico e dovuto che un testo videoludico profondamente narrativo non possa far altro che evolversi in un comparto audiovisivo fortemente esplicativo.
Solo che Mass Effect lo fa, e con risultati migliori di quanto visto sin’ora, riuscendo ad offrire l’Universo con tutto il suo carico di inquietudine e suggestioni, di solitudine e abbandono, di ignoto e tecnologia che solo una grande Space Opera cinematografica o un grande romanzo sci-fi potrebbero permettersi.
 Ed ecco la plausibilità di Mass Effect: situazioni etiche, etniche e sociali di un futuro fantascientifico, colonizzazioni, integrazione etniche ed etiche religiose, politiche governative, spionaggio industriale e immancabili discussione a proposito di IA, di organismi “Sintetici” e Intelligenze Virtuali. Si tratta di universo incredibilmente credibile, capace di emanare una presenza ed una autorità videoludica che totalmente esplodono in un puro spirito fantascientifico come non se ne vedeva da tempo, dall’impagabile coinvolgimento sensoriale. Un’esperienza con una forte ed elegante personalità, nonché di un viaggio molto letterario nel quale i tratti contraddistintivi del genere Sci-fi emergono talmente forte che l’esperienza che ne risulta é in linea con un certo modo di intellettualizzare le realtà del gioco, oltre che di viverla giocando.
Ed ecco la plausibilità di Mass Effect: situazioni etiche, etniche e sociali di un futuro fantascientifico, colonizzazioni, integrazione etniche ed etiche religiose, politiche governative, spionaggio industriale e immancabili discussione a proposito di IA, di organismi “Sintetici” e Intelligenze Virtuali. Si tratta di universo incredibilmente credibile, capace di emanare una presenza ed una autorità videoludica che totalmente esplodono in un puro spirito fantascientifico come non se ne vedeva da tempo, dall’impagabile coinvolgimento sensoriale. Un’esperienza con una forte ed elegante personalità, nonché di un viaggio molto letterario nel quale i tratti contraddistintivi del genere Sci-fi emergono talmente forte che l’esperienza che ne risulta é in linea con un certo modo di intellettualizzare le realtà del gioco, oltre che di viverla giocando.Un appannaggio di pochissime opere video ludiche nelle quali agenza e narrazione generano quell’alto valore che potrebbe condurre i “videogiochi” all’arte del futuro.
Nel tanto parlare di riconoscimento culturale dell'arte Video Interattiva, si tratta di qualcosa non da poco, oggi.










 Sparare.
Sparare.